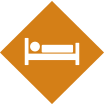Situata a Pianello Vallesina, è uno dei più raffinati singolari esemplari di architettura neoclassica delle Marche d’epoca napoleonica. La sua costruzione è legata alla famiglia Salvati, originaria di Rosara, nei pressi di Ascoli Piceno, e residente a Monte Roberto dal 1750 dove, uno dei suoi componenti, Benedetto, era stato nominato medico. Fu realizzata tra il 1805 e il 1820 su progetto di Giuseppe Camporesi (1763-1822), uno dei maggiori architetti del Neoclassicismo italiano. L’interno della villa si qualifica per la ricchezza e la varietà degli ornamenti decorativi, dagli stucchi con motivi geometrici, che formano soffitti e lacunari intervallati da elementi vegetali e floreali e continue citazioni tratte dalla classicità, a sculture femminili a tutto tondo che campeggiano nelle nicchie dei singoli pianerottoli. Completa l’intero complesso la vicina cappella di famiglia, dedicata a San Serafino, a pianta centrale con colonne corinzie in elegante neoclassico. Vi è sepolto chi volle la villa, Serafino Salvati (1755-1835). Il monumento funebre con effige è di Fedele Bianchini (1791-1867). La pala d’altare, il Matrimonio di Maria e Giuseppe, è copia dell’originale di Carlo Maratti (1625-1713).
E’ sede dal 1960 dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente succeduto alla Scuola Pratica di Agricoltura voluta per testamento del 1923 dall’ultimo dei Salvati, Serafino (1879-1924).
La Villa è gestita dalla Fondazione “Serafino Salvati”.

Maiolati sorge su una collina a 412 metri sul livello del mare. Come gli altri castelli che fiancheggiano la media valle dell’Esino è di origine medioevale. Nel sec. XIII Maiolati e la Villa di Talliano, ubicata a metà della collina che scende verso l’Esino, erano due piccoli centri posti a breve distanza uno dall’altro. Per la sua posizione, Maiolati, ben presto si trasformò in castrum, ebbe cioè un sistema difensivo e già dalle prime decadi del Duecento fece parte del Contado di Jesi fino al suo scioglimento avvenuto nel 1808. La Villa di Talliano, come tante altre “ville” della Vallesina, era sorta dopo il Mille come ampliamento di una curtis, cioè un complesso di possedimenti fondiari frazionati e dispersi, un’unità patrimoniale e aziendale che, appartenendo al vescovo di Jesi, fu contesa dalla città nel 1262 acquisendone tutti i diritti. Poco lontano sorgeva la chiesa di San Sisto di Talliano con l’adiacente monastero. Con tutta probabilità chiesa e monastero furono fondati da monaci provenienti dalla vicina abbazia di S. Elena sull’Esino, ad essa infatti appartenevano nel 1199. Nel 1305 chiesa e monastero subirono gravi danni ad opera dei fabrianesi in guerra con Jesi. In luogo dell’antico monastero sorge ora la chiesetta di S. Sisto ricostruita verosimilmente nel sec. XVIII-XIX. Nella zona sono stati ritrovati manufatti d’epoca neolitica e d’epoca romana come del resto analoghi reperti d’età romana sono stati rinvenuti in contrada Massarella ad est di Maiolati. L’intera dorsale tra il VII e il IX secolo venne a trovarsi nel mezzo della fascia confinaria tra il Ducato longobardo di Spoleto-Camerino e la Pentapoli bizantina: molti dei dominus loci poi assurti a capo dei borghi fortificati e quindi dei castelli sono di estrazione longobarda.

Itinerario n° 6 - Cupramontana, Pian della Casa, Apiro, Fosso dell' Ubriaco, Cervara, Valcarecce, Colognola, S. Pietro, Staffolo, San Paolo, S. Michele, Cupramontana.
Partenza dal parcheggio antistante la cantina di Colonnara. Di qui in direzione del centro, prendere la strada che porta a Staffolo. Proseguire per la strada asfaltata, fino all'incrocio di Pian della Casa e girare a dx in direzione di Apiro.
Giunti ad Apiro (visita), dirigersi ai Piani di Apiro, in prossimità della piscina seguire la strada in discesa che fiancheggia la pineta, proseguire fino ad incrociare la strada bianca, girare a dx e subito dopo, di nuovo a dx a fianco della chiesetta, imboccare la sterrata in discesa in mezzo al bosco (attenzione discesa pericolosa). Dopo aver terminato i tornanti pietrosi, si sale leggermente attraversando una zona coltivata, per poi ridiscendere attraverso la boscaglia fino alla strada asfaltata. Girare a sx e subito dopo di nuovo a sx per la strada asfaltata che conduce alla sorgente di Crevalcuore; seguire la strada asfaltata per circa due Km e dopo una leggera salita si arriva ad un incrocio in prossimità di un dosso; girare a sx e proseguire in salita sulla sterrata fino a giungere alle case abitate di Valcarecce. Alla fine del paese girare a dx, oltrepassare un lavatoio e proseguire sulla strada bianca, in prossimità di un dosso con incrocio mantenere la dx, seguire la strada prima in discesa poi in leggera salita fino alle case abitate (Ca de Berti), all'incrocio girare a sx per la ripida salita che conduce alla chiesa di Colognola, al successivo incrocio contaddistinto dal grande Crocefisso metallico girare a dx, seguire la strada principale che scende dolcemente e dopo una leggera salita, oltrepassate alcune case abitate, girare a dx per una ripida discesa che porta al torrente dell'Acqualta; da qui si sale fino a San Pietro per poi giungere a Staffolo. Scendere in direzione San Paolo, e proseguire fino al centro abitato.
Giunti a San Paolo, in prossimità del monumento ai Caduti, imboccare la strada asfaltata che conduce alla Contrada Peschereccia, seguire la strada asfaltata che sale fino alla fonte Barbanera, girare a dx e segure la strada di ghiaia che porta in fondo alla vallata fino ad incontrare il fosso di Follonica.
Oltrepassato il primo ponte girare a dx in direzione del secondo, dove inizia una lunga e difficoltosa salita che conduce al paese di San Michele; dopo ca 1700 mt si arriva alla chiesa di San Michele, altrepassata la quale girare a sx imboccando la strada bianca indicata dal cartello stradale "Contrada Colonnara"; dopo aver percorso ca 600 mt in un falso piano si arriva in un incrocio, girare a dx ed iniziare a salire con molta calma perchè in ca 1300 mt si supera un dislivello di ca 200 mt con pendenza media del 16 %. Arrivati alla fine della salita, contrassegnata dal segnale "Stop", per ritornare al punto di partenza proseguire in direzione del "Conad", come indicata dalle freccie segnaletiche.
Lunghezza ca Km 35
Tempo di percorribilità ca 3 h
Percorso di lungo e di media difficoltà - tratto finale difficoltoso