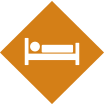La fornace è tornata a rivivere come centro di incontro comunitario attraverso nuove progettualità. Vari sono i luoghi di aggregazione all’interno dell’area complessiva: biblioteca, caffè letterario, informagiovani, sala Joyce Lussu, Gruppo Solidarietà, con annesso centro documentazione. Tutti questi spazi vivono sotto lo stesso comune multiplo denominatore eFFeMMe23, che è l’acronimo di Fornace Moie, mentre 23 fa riferimento al 1923, l’anno in cui la fornace viene dotata del forno Hoffmann ed è casualmente anche il numero civico dell’intera area.
La Fornace da laterizi cessata ogni attività nel 1974 ed entrata per lascito tra le pubbliche proprietà ha subito, dopo un lungo iter burocratico e progettuale, un restauro conclusosi nel 2007 diventando un chiaro esempio di recupero di archeologia industriale.
La sua trasformazione in Biblioteca con servizi plurimi è ormai un frequentato e ricercato polo culturale.
L’aver mantenuto le volumetrie, la ciminiera ed il Forno Hoffmann del 1923, ne fa un luogo storico che perpetua il legame della storia sociale del luogo con i nuovi ruoli culturali che questo spazio offre alla popolazione e alle nuove generazioni.

A Castelplanio è stato concesso il titolo di città in virtù di un decreto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dell’11 luglio 2006 su proposta del Ministro dell’Interno.
Senza voler risalire agli antenati e limitando il campo della ricerca a partire dagli Anni Cinquanta e Sessanta, dal dopoguerra in poi la crescia sul panaro era considerata un alimento povero della cucina del nostro territorio, che si preparava con pochi essenziali ingredienti. Si partiva dalla polenta, e cioè dalla farina di granturco cotta nell’acqua dentro un apposito contenitore (il “callaro”) dove veniva rimestata continuamente a mano con l’ausilio di un arnese da cucina, una sorta di lungo cilindro di legno con tre o quattro sporgenze metalliche sul fondo denominato mestolo.
La crescia veniva confezionata con la polenta avanzata del giorno prima perché, in tempi grami come quelli di cui stiamo parlando, non ci si poteva permettere il lusso di sprecare alcunché e, piuttosto che lasciarla inutilizzata o mangiarla controvoglia, la polenta fredda si riutilizzava mescolandola con un po’ di farina di grano, si impastava nuovamente (stavolta a mano) dando forma alla cosiddetta “cresciola”. Poi si passava al panaro, cioè su una piastra metallica dotata di lungo manico, una specie di padella senza bordi che ancora si può ammirare nelle nostre case di campagna appesa al muro o al caminetto, oggetto di ornamento, non più strumento di lavoro.
Tolta dal fuoco, si guarniva con verdura (bieta, cicoria, erbe di campo…), oppure con prosciutto o salsiccia e si presentava anche in forma di dolce una crescia non più passata per il panaro ma fritta e ricoperta da uno strato di zucchero. Una delizia, non solo per i bambini.
Ed ecco servita la crescia, gustosissima, appetitosa, fumante, bella da vedere e da addentare come né più né meno accade ancora oggi più che altro per sfizio di stagione. Un piatto rustico e poco costoso che doveva soddisfare quasi da solo l’appetito, e in non pochi casi la fame, dopo il duro lavoro nelle campagne dalle prime luci dell’alba al tramonto. Più che sul piatto, però, si mangiava come oggi tenendola con le mani avvolta da un grande foglio da imballo di colore giallo.
Il raggiungimento di un certo benessere generale in epoca di boom economico ha fatto diventare quasi una moda recuperare gli antichi sapori della nostra cucina di un tempo; così sono state create le premesse per la riscoperta della crescia sul panaro e, fatalmente, è scoccata la scintilla - un’idea che si è mostrata davvero lungimirante - di proporre una sagra estiva che data ormai da 40 edizioni, compresa questa del 2013.
Con alcune provvidenziali varianti: non più, dopo un po’ di anni, il faticosissimo mestolo da mulinare a mano per un tempo interminabile, ma un ben più pratico braccio meccanico che agisce automaticamente nel recipiente-impastatrice.
E poi, con un pizzico di fantasia, si è pensato di arricchire la crescia fritta non solo di zucchero ma anche, in alternativa, spalmandola di cioccolata (la comunissima nutella): un prodotto per golosi preferito soprattutto dai giovanissimi.
Castelplanio, confermano molti dei nostri visitatori che ci vengono a trovare dai paesi limitrofi, dalla Vallesina, da tante località della provincia di Ancona e qualche volta anche da fuori, è rimasto uno degli ultimi luoghi delle Marche ad avere mantenuto a un eccellente livello la tradizione della crescia. E così la cittadina in luglio si mobilita per celebrare questo rito collettivo che, per fortuna, continua magicamente a incontrare il favore del pubblico.
E nel 2013, festa speciale per il 40° anniversario della Sagra della crescia sul panaro (1974-2013) a cura della Pro loco Castelplanio con due week end lunghi (12-14 luglio e 19-21 luglio) con al centro dell’attenzione la celebre crescia castelplanese.

Itinerario n° 5 - Cupramontana, S. Marco, Calapina, Castelbellino, Monteroberto, Maiolati Spontini, Cupramontana.
Partenza dal parcheggio antistante la cantina Colonnara. Da qui in direzione del centro cittadino, poco prima del Paese seguire indicazioni "cimitero", continuare imboccando a sx il viale alberato di fronte al cimitero. Proseguire per via S. Marco ancora a sx nel viale fino ad un bivio, tenere la dx affiancando un capannone ( strada bianca ). Il percorso incontra numerose case e diventa, più avanti, pianeggiante, ma solo per un breve tratto, poi si restringe e si volge in pendenza. Curva a dx e sx e di nuovo un tratto pianeggiante e poi in discesa su fondo sconnesso. All’altezza di una casa nuova, in fondo alla discesa, se la strada comunale è ancora soggetta a lavori di ripristino, bisogna attraversare il terreno coltivato a monte del passaggio privato . Si costeggia una piccola scarpata con delle querce e poi a dx fino a una sbarra ; da qui si può o scendere nella strada o proseguire per il campo. Sulla strada si passa tra una vecchia casa (dx) e un capannone seminterrato e poi dritti fino ad incrociare una strada bianca. Dx in discesa (v. Calapina) , dopo ca 100 mt, a sx su strada pianeggiante, seguire la strada principale per ca 500 mt, prima pianeggianti, poi in salita e di nuovo pianeggianti, nuovo incrocio, sempre dritti ( case a dx) . Incrocio con grande quercia e due strade, una a monte e una a valle della principale, ancora dritti, poi ca 100 mt, dopo una curva a sx ad un incrocio prima della discesa girare a sx in salita. Nuovo incrocio, girare a dx su strada pianeggiante , passaggio tra una recinzione privata e un lavatoio, ancora in salita fino ad una grande villa con parco a dx; dritti in leggera discesa fino all' asfalto (S.P. Castelli di Jesi), a sx sulla S.P. si prosegue fino a Castelbellino. Dopo il Paese, prima delle ultime case, su una curva a sx, prendere la tangente a dx in salita fino a Monte Roberto (ca 800 mt). Sotto le mura del Castello a dx e proseguire dritti fino alla S.P. .
Arrivati all'incrocio ( grande colonna di cemento), girare a dx verso Maiolati Spontini, attraversare il Paese e dopo ca 1 km (direzione Cupra) prendere a sx su strada bianca (vietata ai camion-adiacente a una villetta). Proseguire fino ad incontrare nuovamente la S.P. e in direzione Cupramontana, per ca 1,5 km, si ritorna al p.to di partenza.
Lunghezza ca 14 km
Tempo di percorribilità 1 h e 15 min
Percorso facile